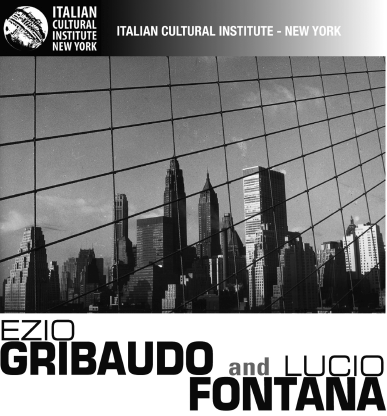Intervista a Ezio Gribaudo, Milano 22 aprile 2006 a cura di Paolo Campiglio
New York, Istituto Italiano di Cultura, dal 5 giugno al 5 luglio 2013
Ezio Gribaudo and Lucio Fontana
Intervista a Ezio Gribaudo, Milano 22 aprile 2006
a cura di Paolo Campiglio
– Paolo Campiglio: Quando ha conosciuto Fontana?
– Ezio Gribaudo: Ho conosciuto Fontana in un momento magico, alla fine degli anni Cinquanta, quando l’artista era già noto per i suoi Concetti spaziali. Ricordo a Torino una mostra organizzata dall’Ente del Turismo, Arte in vetrina, una di quelle iniziative volte a divulgare l’arte contemporanea anche al pubblico più comune, in cui Fontana aveva esposto un Concetto spaziale nella vetrina del negozio Galtrucco. La vetrina era dominata dal solo Concetto spaziale. Fontana aveva fatto scalpore perché, per provocazione, aveva scritto che il quadro costava un milione. E allora la gente non ci credeva, anzi rideva. Quando l’ho conosciuto io era proprio in un periodo di antipittura. L’esordio di Fontana a Torino, è al Center of Aesthetic Research, dove incontra Michel Tapié e con me getta le basi per il libro Devenir de Fontana (1961) uno dei pochi studi monografici sull’artista concepito come libro e non come un catalogo di mostra. Si tratta di un volume che io realizzai per la Fratelli Pozzo nel 1960. Il mio approccio con Fontana è stato di amicizia, e lo ricordo come un guascone argentino dall’accento milanese (un accento che io capivo bene date le mie origini brianzole). Capivo anche il suo spirito. Era un uomo elegante: non aveva l’aria dell’artista del Bar Giamaica, anche se era attorniato dai vari Baj, Crippa, Dova, autori più giovani che, invece, si atteggiavano da artisti; egli si distingueva dagli altri per lo stile. Non si dava arie ma intanto procedeva nella ricerca, apriva veramente nuove strade.
– P.C.: in occasione della mostra da Martha Jackson lei si è recato con Fontana e Tapié a New York, anche per presentare il libro Devenir de Fontana. Può raccontarmi come è andata?
– E.G.: siamo partiti da Milano noi tre e il fotografo Aschieri. L’artista inaugurava la mostra del ciclo dedicato a “Venezia” presso la galleria Martha Jackson, una iniziativa finanziata da Marinotti. Io feci il catalogo della mostra, con quella copertina verde fustellata, ma a New York soprattutto presentammo in quell’occasione il libro Devenir de Fontana appena editato. Avevamo realizzato una tiratura in inglese che andò quasi esaurita. Fu l’occasione per conoscere dal vero tutti i grandi protagonisti dell’Action Painting americana, da Hans Hofmann a Clifford Still a Kline a Motherwell. Vennero tutti all’inaugurazione da Martha Jackson e alla presentazione del libro. Si trattava di un volume, in effetti, un po’ speciale, quasi un libro d’artista, con i neri straordinariamente vellutati dovuti alla stampa in “rotocalco piano”. Un libro di un’attualità tecnica straordinaria. Posso raccontarle qualcosa di questo volume: ho chiesto un testo a Tapié, uno scritto un po’ ermetico come quelli che andavano di moda in quegli anni. Tapié era il profeta del’art autre. Fontana, che aveva la qualità di entusiasmare tutti, era un guascone, parlava del concetto spaziale in un modo un po’ stravagante, mi aiutò a fare il libro e in quell’occasione andai spesso da lui a Milano. La sua “filosofia”, che era semplice – Fontana non era certo un teorico – era basata sul Manifiesto Blanco redatto in Argentina. Fontana era un uomo semplice e ha trovato in Michel Tapié un interprete che lo ha sedotto. Tapié era un persuasore occulto, un personaggio nietzchiano e molto affascinante, un grande dandy: girava per Torino con il monocolo (a Torino c’era solo Lucio Ardendi che aveva il monocolo); aveva un viso da aquila che mi ricordava il nostro architetto Mollino; era di un’eleganza nobile. Come è noto, egli proveniva da una famiglia aristocratica, i Tapié de Ceyleran di Albi, parenti di Toulouse-Lautrec. Aveva un’aria molto decadente, ma con quella decadenza aulica, imperiale. Io, oltre che essere stato il primo suo editore, sono stato molto affascinato da Tapié, perché era il mio profeta, il profeta dell’art autre. Ho fatto con lui libri unici come la Morfologie Autre, una sorta di glossario della terminologia “autre”, con tutti gli artisti europei, ma soprattutto americani a cui il critico dava spazio. Tapié andava in cerca di artisti in America e poi li presentava in Europa. Io sono stato il primo disposto a pubblicare questi materiali allora poco noti o addirittura sconosciuti, muovendomi da solo. Oggi è più facile pubblicare, si hanno appoggi da parte degli Enti locali, allora non era così. Devo aprire, a riguardo, una parentesi, per spiegare che tipo di casa editrice era la Fratelli Pozzo, per cui lavoravo. Si trattava di una tipografia, nota per stampare gli orari ferroviari, in cui io per primo introdussi edizioni d’arte d’avanguardia e di pregio. Giuseppe Marchiori un giorno, con ironia, mi disse che dagli orari ferroviari eravamo passati all’arte informale perché trovava anomala questa esperienza editoriale. Dopo il mio primo libro, Morfologie Autre, il mio presidente, un vecchio colonnello della guerra del 1915-1918, mi disse che a suo giudizio si trattava di un libro di spionaggio, perché al posto delle opere vedeva delle mappe, quasi rivelassero siti nascosti, basi atomiche. Però, nonostante i sospetti, mi buttò il suo arto finto sulla spalla (era un mutilato di guerra) e mi incitò a continuare perché era convinto che fossi un giovane intelligente.
– P.C.: tornando a New York, ha altri ricordi del soggiorno americano?
– E.G.: certamente. Restammo a New York una decina di giorni. Noi soggiornavamo all’Hotel Adams, sulla Settantaquattresima, vicino al Metropolitan; Fontana era un po’ in difficoltà perché il portiere parlava in inglese e lui non conosceva la lingua. In Hotel eravamo noi tre e il fotografo Aschieri. Avevamo le camere al quattordicesimo o quindicesimo piano: ogni volta che l’ascensore saliva a gran velocità Fontana si emozionava e alle nostre battute sull’eventualità che l’ascensore si rompesse, rispondeva insultandoci scherzosamente. Ci siamo proprio divertiti con lui. A New York si aggiunse a noi il pittore Enrico Donati, amico di Fontana e Crippa, che aveva aderito allo Spazialismo e che aveva lo studio nella metropoli americana: Donati procurò all’artista diversi incontri. Mi ricordo che all’inaugurazione da Martha Jackson venne Ruggero Orlando e c’era la televisione. Dovrebbe esserci negli archivi RAI una registrazione o una trasmissione in cui ci siamo io lui e Fontana. Poi all’inaugurazione c’era Leo Castelli, che già allora mi invitò a vedere i suoi Oldenburg e Rauchenberg in galleria. Io che avevo intuito qualcosa ed ero convinto di inaugurare un nuovo e proficuo rapporto con Castelli, feci l’errore di dirlo a Tapié, che mi depistò e mi convinse a lasciare perdere con i suoi affascinanti argomenti, citando la “metaphisique de la matiére”. Ricordo che in quei giorni andai personalmente a conoscere Duchamp con Donati, ma Fontana quella mattina non venne.Il fotografo Aschieri, con cui dividevo la camera, era sempre con me e ha scattato numerose foto. Quando andai da Samuel Kootz, il grande mercante di Picasso, quello mi prese in giro dicendomi che in America solo il Presidente ha un fotografo personale che lo segue.Tornando alla mostra di Fontana, era effettivamente un “elogio” alla materia. Il ciclo delle opere dedicate a “Venezia”, con le citazioni anche “barocche” delle volute della Salute, era un omaggio all’Oriente e alla città lagunare che rivelava allora, in fondo, il suo innamoramento per la pittura, la sua sensualità, lontano dai razionalismi: però, sia chiaro, Fontana non faceva pittura. Aveva bisogno della materia. Ripeto, era un uomo semplice, non era un artista concettuale come molti lo vogliono credere oggi.
– P.C.: le risulta che Fontana sia andato a Pittsburg una sera ospite nella “villa della cascata” di Wright? Perché c’è una missiva a un amico italiano in cui racconta di una serata passata in compagnia del proprietario della villa Kaufman.
– E.G.: lui probabilmente andò. Io no. Però non sono nemmeno sicuro che sia andato. A Fontana piaceva scherzare e prendere in giro gli amici. Raccontava un sacco di storie, anche divertenti, tutte inventate. Pensi che quando eravamo a New York mi inviò una lettera a Torino chiedendomi dove ero finito, ed ero lì nel suo stesso albergo! Ricordo anche che al ritorno da New York, volavamo con l’Air France, a Parigi è stato male ed ha avuto una piccola crisi cardiaca.
– P.C.: al ritorno in Italia, ma già a New York, l’artista, affascinato dalle luci della metropoli e dai riflessi luminosi dei grattacieli, darà vita al ciclo dei “metalli” dedicati al soggiorno newyorchese.
– E.G.: già durante la lavorazione del libro ricordo che, quando Fontana veniva alla Pozzo a seguire le singole fasi, dalle fustelle alla copertina, era attratto dalle lastre sottili di rame del rotocalco. Il rame è malleabile e lui lo aggredì con dei punteruoli. Aveva voglia di cambiare, era appassionato alle tecniche, quelle della bottega. Allora avevo fatto fare a Fontana dei lavori con dei papier Buvard (carte assorbenti) che usavo anch’io, con i quali pervenni poi ai miei celebri Logogrifi, che hanno vinto il Gran Premio della Grafica alla Biennale del 1966.Ricordo che al ritorno da New York, dove era stato affascinato dai grattacieli, Fontana fece un intervento a graffito con un punteruolo, delle incisioni su una carta dorata lunga un metro, con motivi quasi alla Tobey; realizzò un’opera unica, che rappresenta in un certo senso un incunabolo del ciclo dei “metalli” sviluppato successivamente; la carta presentava anche delle pennellate argento, con cui raffigurava sinteticamente i grattacieli.
– P.C.: prima del progetto del libro dove aveva conosciuto Fontana?
– E.G.: ad Albisola, dove ormai lui era attorniato da molti artisti ed era una celebrità. Ricordo di esser stato a Pozzo Garrita e di aver visto Jorn e Appel, un uomo grandissimo, un olandese che sembrava l’”uomo delle nevi”. Fontana in mezzo al gruppo di Albisola si distingueva per il suo stile: erano tutti gelosi della sua arte. Aveva uno stile straordinario. Se avessi avuto la penna di Joyce avrei già scritto un romanzo sui miei ricordi. Ma mi sembra di avere già fatto abbastanza nella mia vita.